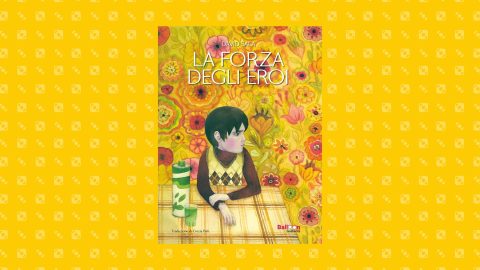Che la musica – quella live soprattutto – sia una questione di business non risulta né nuovo né sorprendente. Così come non lo è il fatto che un settore economico d’oggigiorno renda la vita impossibile al settore medio e faccia ricadere il peso della crisi post-pandemica sui consumatori. Parlando di festival, ci troviamo a raccontare una storia già stra vista e stra raccontata nell’epoca del realismo capitalista.
La storia inizia agli albori dei 2000, quando iTunes fa scattare l’allarme fra i discografici, e diffonde la consapevolezza che la vendita di copie fisiche ricoprirà un ruolo sempre più marginale. Se prima i tour erano la promozione del disco, ossia il prodotto che si voleva spingere, ora i confini sono ben più opachi. I festival, che già negli anni ‘90 avevano mostrato accenni di mercificazione dell’esperienza – vedi il tragico Woodstock ‘99 – rimangono incastrati nell’occhio del ciclone, ma non da subito. Vivono prima un periodo di grazia, nel quale proliferano nuove iniziative dal basso, anche perché le band di piccole-medie dimensioni e ambizioni hanno bisogno di opportunità di esibirsi che siano commisurate alla loro notorietà.
È quello che ci ha raccontato Giuseppe Carminati, facente parte dei volontari di FilagoGiovani che hanno fondato il Filagosto Festival, un evento nato come una “festa” organizzata da ragazzi associatisi per fare del bene al territorio, contando proprio su queste band di media portata che oggi scarseggiano.
Il Filagosto, che negli anni aveva portato sul palco Dargen D’Amico, Generic Animal, Coez e tanti altri nomi di peso nazionale, è stato costretto a sospendere l’edizione 2025. Quello che, limitandosi alla notizia, si potrebbe intendere come caso specifico con cause specifiche – il non rinnovo della convenzione con lo spazio privato che ha ospitato il Filagosto negli ultimi anni – nasconde una dimensione sistemica del problema ben più grave. Il passaggio fondamentale è l’ingresso in campo di un attore destabilizzante, ossia i gruppi finanziari. L’industria del live diventa il regno dei capitali esteri, quest’ultima una caratteristica fondamentale, in quanto le decisioni sui festival vengono prese da chi non ha nessun legame con il territorio, né alcun interesse a mostrarsi come imprenditore illuminato. Il risultato è che chi frequenta i festival ha sempre più la sensazione di vivere ogni volta lo stesso evento, con gli stessi artisti e gli stessi – esorbitanti – costi. Come racconta Federico Rasetti, crolla la diversità imprenditoriale, la capacità di presentare un’offerta diversificata al pubblico nonché ai manager degli artisti, che ormai non possono che puntare al grande pubblico generalista, perché sotto non c’è niente. In Italia, l’azione predatoria dei gruppi finanziari si affianca a una scarsissima collaborazione degli enti locali, incapaci di afferrare il valore della vivacità culturale per comunità e territori, senza
contare le opportunità economiche offerte dal turismo da festival.
C’è da aggiungere che, con il tempo, il pubblico si è sempre più adattato alla standardizzazione e alla concentrazione dell’offerta di festival, soprattutto nel periodo post-pandemico. Will Page, ex chief economist di Spotify, parla di consumatori che spendono i propri risparmi concentrandoli su un paio di grandi eventi piuttosto che spalmarli su più festival medio-piccoli. Uniteci il fatto che dopo il Covid i soldi in tasca da spendere sono di meno per tutti, e il danno è fatto. Le riflessioni di Page – che è scozzese – ci consentono inoltre di mettere a fuoco un’ultima caratteristica della festival crisis: la sua transnazionalità. Diversi paesi con diversi background socio-culturali sembrano soffrire di problemi essenzialmente identici. Nel Regno Unito 78 festival sono stati annullati solo nel 2025, una cifra che
probabilmente crescerà fino a superare quello del 2024, che NPR aveva decretato essere “l’anno in cui il festival musicale è morto”.
Come ogni problema complesso, la crisi interessa tante dimensioni che si intersecano. La crisi economica si affianca – e in buona parte determina – la crisi artistica. I festival e i piccoli club sono il principale strumento con cui band medio-piccole si affacciano al loro potenziale pubblico. Se sono le multinazionali del live a organizzarli, la lineup di un festival non è più costruita secondo una direzione artistica, con l’intenzione quindi di presentare nuovi artisti a un pubblico capace di accoglierli. Lineup e pubblici ugualmente generalisti si confondono l’un l’altro in fake festival che assomigliano più a rassegne, a riassunti dei primi posti delle classifiche globali. E dal punto di vista musicale, è questa la vera tragedia.