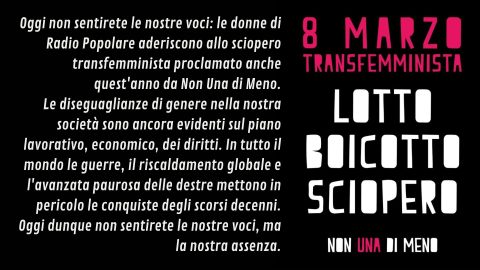Oggi se posso vorrei raccontarvi un ricordo personale, una cosa di quattro anni fa, quando lavoravo all’Espresso e lì pubblicammo una delle prime inchieste sulle condizioni dei rider, che allora erano un settore di lavoro tutto nuovo in Italia.
Dopo quell’articolo venne a trovarmi uno dei due amministratori delegati di Foodora, azienda di delivery tedesca che oggi nel nostro Paese esiste più, è confluita in Glovo.
L’amministratore delegato, un trentenne sorridente, è arrivato in redazione accompagnato dal suo addetto stampa e mi ha spiegato che nel nostro pezzo avevamo sbagliato tutto, che non avevamo capito lo spirito della loro impresa. Loro infatti non sfruttavano proprio nessuno ma anzi il contrario: si rivolgevano ai ragazzi che amavano andare in bicicletta e addirittura li pagavano per coltivare il loro hobby, cioè le due ruote.
Insomma, era un accordo “win win”, mi spiegò in aziendalese: Foodora poteva offrire il suo servizio di food delivery, i ragazzi erano contenti perché qualcuno era così gentile da pagarli per andare in bici.
Quindi la mia visione “sindacalizzata” era vecchia e superata di fronte alla gig economy.
L’incontro non finì benissimo, come avrete capito, i colleghi mi presero in giro per due giorni dopo aver sentito – anche a parecchie stanze di distanza – la mia reazione non proprio pacata.
Non ho mai più incontrato quel tizio trentenne, in Italia appunto Foodora non esiste più, vedo su Internet che ora è a capo di un’altra start-up.
Auguri a lui, naturalmente, e niente di personale.
Ma oggi, quattro anni dopo e dopo la liberazione dei ciclofattorini da quella che il procuratore capo di Milano Francesco Greco ha definito “schiavitù”, forse possiamo vedere meglio quale delle due visioni era “vecchia”: quella del cottimo travestito da hobby o quella della tutela dei diritti degli esseri umani, anche e soprattutto al tempo della gig economy.